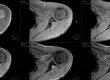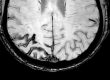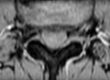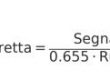Buongiorno a tutti. In questa a presentazione affronterò l’argomento dell’acquisizione del DATASET immagini di risonanza magnetica descrivendo i vari aspetti delle nuove bobine e dei mezzi in parallelo per poi arrivare a definire quelli che sono i metodi lavorativi principali di questo tipo di applicazione.
IN FONDO AL TESTO SONO STATI INSERITI I 4 VIDEO CON LA PRESENTAZIONE COMPLETA
I punti più importanti che dovremo prendere in considerazione per questo tipo di applicazione sono i concetti base di fisica, le caratteristiche del K-spazio, i metodi di riempimento del K-spazio, le nuove bobine in parallelo, le varie informazioni sui tessuti e il dettaglio anatomico, seguite dalle applicazioni pratiche di questi aspetti.
Per quello che riguarda la fisica accenniamo velocemente un riassunto di base ricordando che gli atomi di idrogeno presenti nel corpo umano, quando vengono introdotti all’interno di un campo magnetico statico di una determinata intensità, tendono a disporsi nella stessa direzione del campo magnetico principale ma in due sensi differenti: uno nel senso parallelo al campo magnetico stesso e uno nel senso opposto. Il numero di atomi di idrogeno disposti in senso parallelo saranno lievemente maggiori del numero di atomi di idrogeno disposti in senso anche parallelo: è proprio sulla differenza tra queste due popolazioni che potremo andare ad agire utilizzando un impulso a radiofrequenza. Un impulso a radiofrequenza inviato con la stessa frequenza degli spin in esame riuscirà a creare due differenti effetti: il primo di modificare la direzione della magnetizzazione creata dagli spin stessi spostandola dalla direzione longitudinale (nello stesso senso del campo magnetico principale) alla direzione trasversale in senso perpendicolare al campo magnetico principale; il secondo effetto sarà quello di mettere in fase tutti gli spin che ruotano contemporaneamente all’interno del magnete andando quindi ad aumentare la componente trasversale. E’ proprio su questa componente trasversale che andremo a lavorare nella lettura del segnale esterno da parte di una bobina di ricezione posta perpendicolarmente al campo magnetico principale.
Nel momento in cui l’impulso di eccitazione di radiofrequenza viene interrotto avverrà un ritorno alle condizioni iniziali da parte degli spin che erano stati precedentemente eccitati, che creerà un segnale di ritorno all’interno della bobina.
Il segnale che si formerà all’interno della bobina appena descritta avrà le classiche caratteristiche di un’onda di radiofrequenza con aspetto di tipo sinusoidale, quindi un segnale che periodicamente aumenta e diminuisce, e che potrà essere descritto da tre parametri principali. Il parametro più importante sarà sicuramente il tempo, all’interno del quale questa curva si svolgerà, un altro parametro importante sarà quella dell’ampiezza, cioè l’altezza della curva, ed infine la frequenza che rappresenterà il numero di cicli nell’arco di un secondo.
In sostanza, quando la magnetizzazione trasversale si trova nel punto più vicino alla bobina l’intensità dell’onda sarà più elevata; quando la magnetizzazione trasversale ruoterà allora l’ampiezza dell’onda diminuirà progressivamente, passando per lo zero, per poi tendere al valore negativo minore possibile nel momento esatto in cui la magnetizzazione trasversale si troverà in direzione opposta al punto di dove si trova la bobina ricevente.
Nel contesto del tempo, un’altra caratteristica della nostra onda di radiofrequenza sarà la fase, che rappresenta il punto iniziale di partenza del segnale della radiofrequenza.
Se si dovessero descrivere diverse onde di radiofrequenza nel dominio delle frequenze si potrebbero utilizzare delle rappresentazioni grafiche a barra se ciascuna onda di radiofrequenza fosse caratterizzata da un’unica frequenza. Quindi più la frequenza è elevata e più la barra rappresentante la nostra onda si troverà a destra nell’asse delle ascisse, mentre più la radiofrequenza dell’onda sarà bassa e più la barra della radiofrequenza si troverà verso sinistra.
Se invece fosse l’ampiezza a variare allora sarà l’altezza della barra rappresentante la nostra onda a dover variare.
Le cose purtroppo si complicano quando ci si trova davanti a un’onda composta da una frequenza variabile. In questo caso la curva non sarà più rappresentata da una barra stretta ma sarà rappresentata da una superficie con una base estesa.
Quando si vuole andare ad esaminare una parte del corpo si dovranno andare a discriminare i segnali di ciascuna unità che vuole essere analizzata. Nel contesto della tecniche di risonanza magnetica, come sappiamo, il volume viene suddiviso in piccole unità chiamate pixel oppure, considerando anche lo spessore, unità chiamate voxel. Sarà proprio da ciascuna di queste singole unità che dovremmo poter ricevere segnali separati e distinguibili. Ma se si inviasse un segnale unico per tutti tessuti ad una determinata frequenza riceveremmo in risposta una serie di segnali con la stessa frequenza e quindi non distinguibili l’uno dall’altro.
Dovremo quindi inventarci un sistema per poter ricevere dei segnali differenti a seconda del punto preciso da cui provengono. Un primo metodo potrebbe essere quello di utilizzare delle frequenze differenti, per esempio inviando a ciascuna colonna uno stimolo con frequenze differenti.
Per differenziare invece le differenti righe si potrebbe andare a creare una differenza di fase delle onde inviate. Il risultato finale di queste onde con caratteristiche differenti sarà un insieme di forme d’onda sovrapposte con frequenze e fasi differenti.
Nelle nostre apparecchiature di risonanza magnetica questo effetto può essere ottenuto andando a variare progressivamente l’intensità del campo magnetico statico che viene applicato alla parte in esame. Per esempio, per una RM con campo magnetico 1 T si potrà andare ad applicare una differenza progressiva passando da 0,995 T per arrivare a 1,005 T. In questo modo le frequenze di precessione dei vari spin saranno progressivamente differenti e sarà possibile discriminare tra una zona e l’altra.
Ovviamente questo tipo di differenziazione spaziale può essere eseguita non solo lungo il senso principale del campo magnetico statico ma anche nelle altre due direzioni dello spazio.
Per esempio potrebbe essere applicato un gradiente di codifica delle frequenze lungo la direzione latero-laterale, ovvero l’asse X orizzontale del magnete. In questo modo potrebbero essere discriminate le differenti frequenze da destra a sinistra.
Nel senso dell’asse Y, quello verticale, potrebbe invece essere applicata una differenza per quello che riguarda le codifiche di fase del segnale e quindi riuscire a discriminare i segnali per le differenti caratteristiche proprie per quanto riguarda la fase.
Una volta che sono state raccolte tutte le informazioni relative al segnale di ritorno, queste dovranno essere memorizzate per poter essere poi consecutivamente rielaborate e dare quindi come risultato l’immagine finale. Il K-spazio è proprio quell’entità che ci consente di memorizzare i dati acquisiti per poterli poi trasformare grazie alla trasformata di Fourier nei vari pixel che costituiranno l’immagine.
Ricordiamo allora che l’onda risultante ricevuta nella bobina sarà un’onda complessa, composta da segnali di differenti frequenze e differenti fasi. Quest’onda verrà campionata temporalmente mentre i dati acquisiti verranno inseriti, secondo differenti metodi, nel K-spazio.
Prima di vedere come questi dati verranno inseriti è necessario dare una definizione di quello che è il K-spazio, specificando soprattutto che non corrisponde in modo diretto all’immagine finale ma che rappresenta direttamente le informazioni relative alla campionatura del segnale di ritorno. È composto da due coordinate X e Y, rispettivamente corrispondenti alla decodifica nel senso della frequenza e alla codifica nel senso della fase. Sono assi che andranno a caratterizzare la dimensione dell’immagine e la grandezza dei pixel che la costituiscono.
Nello specifico, a parità della grandezza del K-spazio, la distanza tra i punti sarà inversamente proporzionale alle dimensioni dell’immagine.
Viceversa a parità di distanza dei punti le dimensioni del K spazio determineranno le dimensioni dei singoli pixel.
Un’altra caratteristica è quella relativa al fatto che la parte centrale delle informazioni contenute saranno relative alle basse frequenze e saranno relative al contrasto delle immagini, mentre le parti più esterne, quindi corrispondenti alle alte frequenze, determineranno la risoluzione dell’immagine e quindi il dettaglio.
Le differenti caratteristiche di riempimento del K-spazio andranno ad influire direttamente sull’immagine risultante finale. Ciascuna tecnica di riempimento (sono 4 categorie principali: standard non ecoplanari, ecoplanari, radiali e spirali) avrà dei pregi ma avrà anche dei tempi di esecuzione differenti che potrebbero non renderla adatta a tutte le applicazioni cliniche e pratiche.
Le STANDARD NON ECOPLANARI sono divise in sottogruppi, ma hanno la principale caratteristica di acquisire le singole informazioni in un tempo relativamente corto rispetto alla durata del decadimento T2*, informazioni che si trovano nell’asse X del K-spazio.
Citiamo quindi quello che è il riempimento di base lineare e rettilineo che riempie ciascuna linea partendo dall’alto a sinistra, tornando a capo ogni volta, per finire in fondo all’ultima linea in basso a destra. Ciascuna linea viene riempita in un TR, quindi per acquisire tutta l’immagine sono necessari N fasi x TR.
Il riempimento di tipo Half Fourier consiste nel riempire solo poco più di metà del K spazio, per poi completare la parte mancante con le informazioni della parte già riempita. Il sistema permette di dimezzare il tempo di acquisizione delle immagini velocizzando notevolmente la sequenza.
Con la tecnica del Partial Echo si va a riempire solo parte di ciascuna riga accelerando quindi il riempimento delle stesse. Con questa metodica si va ad accelerare l’acquisizione delle immagini ma diminuisce anche il rapporto segnale rumore.
La tecnica di riempimento multi-linea consiste nel riempire più linee contemporaneamente utilizzando acquisizioni in contemporanea. Questa metodica consente di accelerare notevolmente il tempo di acquisizione.
Il riempimento di tipo centrico consiste nel riempire prima le linee centrali del K-spazio per poi andare a creare un riempimento delle linee periferiche. In questo modo si va ad acquisire all’inizio dell’acquisizione il massimo delle informazioni relative al contrasto dell’immagine.
Il tipo di riempimento centrico immerso lavora esattamente in maniera opposta andando ad acquisire inizialmente le immagini relative alla risoluzione spaziale, sfruttando un’eventuale rapporto segnale rumore elevati in questa fase, per poi andare a riempire le linee riferite al contrasto.
L’utilizzo di tecniche di interpolazione consiste nel riempire solo alcune linee del K-spazio per andare poi a ricostruire tramite algoritmi specifici e interrogazioni le linee mancanti. Questo tipo di riempimento permette di accelerare notevolmente l’acquisizione delle immagini sacrificando il rapporto segnale-rumore e la definizione dell’immagine.
La tecnica Keyhole consiste nel riempire una volta tutto il K-spazio, per poi andare ad acquisire in scansioni successive, che temporalmente sono molto più veloci, solo la parte centrale del K-spazio in modo da poter utilizzare le informazioni relative alla risoluzione che teoricamente non subiscono variazioni. Questa tecnica è molto utilizzata nelle acquisizioni dinamiche dove l’aspetto morfologico delle immagini non cambia durante il tempo ma cambia invece l’intensità di alcuni tessuti.
Il riempimento di tipo Ecoplanare consiste nel riempire tutto il K-spazio con un solo impulso, riempiendo una linea completamente e passando alla successiva riempiendola poi in modo inverso. Questa tecnica richiede solo un impulso e la geometria del riempimento è differente dalla possibilità di effettuare immagini velocissime. Con la stessa tecnica si possono usare impulsi multipli per riempire il K-spazio sempre velocemente ma con impulsi differenti. L’acquisizione delle immagini singole è molto più veloce della tecnica non EPI, ma l’acquisizione delle singole informazioni è più lunga perchè non riguarda solo una linea ma tutte le linee del K-spazio. In particolare il problema più importante è relativo al tempo di acquisizione delle informazioni, più lungo rispetto alla durata dell’eco, che, soprattutto a causa della relativa lentezza nell’asse Y del K-spazio, va ad aumentare determinati artefatti come il chemical shift o la suscettibilità magnetica.
Le tecniche di adempimento di tipo radiale vanno a creare un sovra-campionamento della parte centrale del K-spazio, assicurando quindi misurazioni multiple delle informazioni relative al contrasto stesso o velocizzare la raccolta delle informazioni per quello che riguarda le informazioni di risoluzione spaziale. Sono ovviamente utilizzate per l’accelerazione dell’acquisizione delle immagini.
Anche le sequenze radiale a gruppi, da alcuni chiamate PROPELLER, consistono nel sovra-campionare la parte centrale del K-spazio e accelerare la parte periferica.
Le tecniche di tipo radiale permettono di acquisire nella prima fase di acquisizione la parte centrale in modo simmetrico per dare ancor più importanza al fattore contrasto, per poi andare ad acquisire nella fase finale (per la tecnica spirale centrifuga) la risoluzione spaziale, o il contrasto per la tecnica di tipo spirale concentrica, chiamata anche spirale-in.
I tipi di riempimento del K-spazio sono da conoscere in modo approfondito perché permettono di ottimizzare la tecnica di acquisizione in base alla capacità della macchina e al tipo di struttura anatomica che bisogna studiare.
Ovviamente entrano in gioco anche molti altri fattori come ad esempio le bobine.
Prima delle recenti evoluzioni si utilizzavano bobine con un solo elemento ed un solo canale di trasmissione, questo faceva in modo che tutti delle informazioni dell’immagine venissero acquisite dalla stessa bobina e quindi doveva compiere i cicli completi di lettura del segnale. Sono stati poi accoppiati più elementi di bobine che permettevano di migliorare il rapporto segnale-rumore e di coprire superfici molto più ampie rispetto a quello che si faceva con un solo elemento. Si è arrivati poi a quella che è stata una delle evoluzioni tecnologiche più importanti in risonanza magnetica, stiamo parlando dell’acquisizione in parallelo.
L’utilizzo di elementi di bobine multiple ha permesso infatti di sviluppare l’acquisizione separata da parte di ciascun elemento di solo una parte dell’immagine o delle informazioni relative all’immagine. Il vantaggio più importante sicuramente è stato quello dell’accelerazione dell’acquisizione globale dei dati. Ricordiamo che in risonanza magnetica le necessità principali sono quelle di avere una ponderazione corretta, una risoluzione spaziale molto elevata, tempi di acquisizione accettabili e assenza di artefatti. Il primo fattore non è direttamente dipendente dagli altri mentre gli ultimi tre in qualche modo sono sempre legati tra di loro.
Ricordiamo quindi che l’acquisizione globale della sequenza dipende anche molto dalla risoluzione spaziale che si vuole ottenere, questo perché proprio ad ogni linea della matrice nel senso della fase corrisponde una decodifica che richiede del tempo per essere effettuata. Ovviamente lo sviluppo tecnologico e l’incremento delle prestazioni dei gradienti hanno portato ad un’accelerazione globale dei tempi di acquisizione. Esistono comunque dei limiti che non possono essere superati a causa dei limiti di SAR e di eventuali possibili stimolazioni nervose al paziente.
Quindi il fulcro di questo discorso è che all’aumentare della risoluzione spaziale generalmente corrisponderà un aumento dei tempi di acquisizione, oppure dovendo diminuire il tempo di acquisizione generalmente si dovrà andar sacrificare la risoluzione spaziale. Cosa ci permette di fare la tecnica di acquisizione parallelo? Ci consente di acquisire in modo molto più veloce i dati, quindi potremo acquisire o sequenze di minor durata oppure andare ad ottenere una maggior risoluzione; scopo finale in ogni caso di questi due aspetti è quello di ottenere una migliore qualità generale dell’immagine finale.
Ovviamente i campi di applicazione di questa tecnica sono sostanzialmente tutte le indagini anche standard che vengono eseguite in risonanza magnetica, ma alcuni tipi di acquisizione giovano particolarmente dei pregi di questa tecnica. Citiamo in particolare quelli che sono le acquisizioni veloci nell’imaging in apnea dell’addome superiore e del torace, le acquisizioni veloci necessarie nell’imaging dinamico con mezzo di contrasto, le immagini in movimento, gli studi angiografici con iniezione a bolo di mezzo di contrasto, e infine gli studi di perfusione e diffusione.
Ripetiamo quindi ancora il concetto di imaging parallelo: nelle tecniche standard una sola bobina acquisisce tutta l’immagine in un tot di tempo, nelle acquisizioni parallele invece un tot numero di bobine acquisiscono un tot di parti dell’immagine, utilizzando minor tempo per poi passare alla successiva ricostruzione dell’immagine finale. Le condizioni per poter eseguire un’acquisizione di tipo parallelo sono principalmente quelle di avere almeno due bobine, ciascuna di esse deve comunicare con un canale di dati separato, ed è necessario avere una mappa di sensibilità spaziale di ciascuna bobina.
Purtroppo non esistono solo vantaggi nell’utilizzo di questa tecnica ma si devono citare almeno due problemi importanti: il primo è quello della perdita di rapporto segnale-rumore nell’ordine della radice quadrata del fattore di accelerazione, il secondo è la comparsa di possibili nuovi artefatti come ribaltamenti particolari al centro dell’immagine oppure zone di registrazione non corretta dei valori del pixel, dovuti alla non corrispondenza tra la maschera di sensibilità e l’immagine che è stata poi successivamente acquisita.
Le principali famiglie di tecniche di acquisizioni in parallelo sono due: la famiglia che lavora sulle immagini acquisite che comprende le SENSE, le ASSET e le PILS, e la tecnica che va a lavorare direttamente sulla trasformata di Fourier, le AUTO-SMASH e le GRAPPA. Nella trascrizione del testo non entreremo nel dettaglio delle tecniche di imaging parallelo.
Quello che è importante capire infine, è che il flusso di dati acquisiti dall’apparecchiatura dovrà poi essere adattato a quelle che sono le applicazioni pratiche classiche della risonanza magnetica. Stiamo quindi parlando degli esami di tipo diagnostico, del follow-up delle patologie sistemiche, degli esami mirati alla programmazione chirurgica o radioterapica, o ancora per le autopsie virtuali.
Gli esami RM di tipo diagnostico hanno la necessità di avere delle buone informazioni sul segnale dei tessuti ma hanno anche la necessità di avere una buona risoluzione spaziale e una buona risoluzione nei piani ricostruiti. Sono di solito degli esami specifici e mirati ad un solo distretto anatomico, eseguiti con ponderazione multiple in modo da ottenere informazioni diversificate eventualmente anche grazie all’utilizzo di opzioni aggiuntive; solitamente necessitano di una risoluzione media elevata e devono poter essere acquisite in tempi relativamente limitati.
Gli esami RM eseguiti per il follow-up delle patologie sistemiche invece necessitano soprattutto di avere delle corrette informazioni sul segnale proveniente dai tessuti senza necessità di avere una risoluzione spaziale esageratamente spinta. Solitamente sono esami che comprendono tutte le parti del corpo e che vengono eseguiti solo in ponderazione specifiche, come per esempio le TSE T1, STIR, o diffusione DWI; le informazioni ottenute normalmente non sono specifiche per un solo organo anche per il fatto che vengono ricercate delle patologie multifocali, per cui è sufficiente una risoluzione media anche a causa del fatto che va coperto tutto il corpo del paziente ed è pertanto necessario limitare i tempi di acquisizioni delle singole sessioni.
Negli studi mirati alla programmazione di microchirurgia o di radioterapia, gli esami RM sono sempre limitati ad un solo distretto anatomico, eseguendo delle sequenze e dei protocolli specifici talvolta richiesti direttamente da chi deve ricevere le immagini; la risoluzione spaziale in questi casi deve essere molto elevata mentre sono più povere le informazioni relative al contrasto dell’immagine, e il set di dati in genere viene poi utilizzato per rielaborazioni multizonali o tridimensionali.
Per quello che riguarda le autopsie virtuali invece gli studi possono essere sia panoramici oppure relativi a un distretto, questo dipende dall’inquadramento che viene fatto dal medico richiedente.
Le acquisizioni sono specifiche per ciascun distretto studiato, solitamente viene richiesta una risoluzione spaziale molto elevata, eventualmente con possibilità di eseguire delle ricostruzioni multi-planari tridimensionali. Il vantaggio in questi casi è che i tempi di acquisizione possono essere anche molto lunghi perché non ci sono problemi di sopportabilità da parte dell’esaminato.
Ovviamente l’equilibrio tra le informazioni raccolte relative alla risoluzione spaziale e le informazioni sul segnale può essere più sbilanciato da una parte o dall’altra, ma il numero di informazioni raccolte per ciascuna di queste due componenti andrà ad influire direttamente sulla durata totale dell’esame. Sappiamo tutti infatti come in risonanza magnetica sia possibile acquisire le informazioni relative ai tempi T1 e T2, alla densità protonica, alla diffusività e al flusso; questo si può ottenere grazie all’utilizzo di differenti sequenze, a cui potranno essere aggiunti dei parametri aggiuntivi come per esempio la risoluzione spettrale o l’eccitazione selettiva o specifiche presaturazioni, ottenendo così il set completo di informazioni. Ma all’aumento del numero di informazioni richieste aumenta anche il tempo totale di acquisizione delle stesse.
Un accenno a quelli che sono i fattori che vanno ad influire direttamente sulla risoluzione spaziale nel piano (2D) e citiamo quindi i tre fattori più importanti che sono il FOV, la matrice nel senso della decodifica di fase e la matrice nel senso della decodifica di frequenza. Il numero di medie non va ad influire direttamente sulla risoluzione spaziale ma va ad inficiare quella che è la qualità generale dell’immagine finale perché consente di diminuire progressivamente la presenza del rumore sull’immagine stessa. Un parametro che non fa parte dell’acquisizione stessa è l’interpolazione dei dati che ci consente di andare ad aumentare artificiosamente la risoluzione spaziale risultante. Ripetiamo quindi che all’aumentare del FOV la risoluzione spaziale diminuisce e il tempo non dovrebbe subire variazioni, all’aumentare della matrice nel senso della fase si ha un aumento della risoluzione e un aumento del tempo, all’aumentare della matrice nel senso della frequenza si ha un aumento della risoluzione spaziale e non è detto che si abbia un aumento del tempo, all’aumentare delle medie si ha un notevole aumento del tempo ma la risoluzione spaziale nominale non cambia, e infine l’utilizzo di interpolazione aiuta il miglioramento della risoluzione spaziale senza inficiare il tempo di acquisizione.
Quando si va invece a parlare di risoluzione 3D entra in gioco la terza dimensione che è rappresentata dallo spessore di strato. Si parla quindi di voxel, che è l’unità di base di acquisizione della risonanza magnetica, le cui dimensioni sono determinate dalle dimensioni del pixel (piano di acquisizione) e dallo spessore di strato. La presenza di eventuali rumore sull’immagine in questo caso può creare problemi, e come per la risoluzione del piano accennata precedentemente le interpolazioni possono aiutare a migliorare la risoluzione nel senso dello strato.