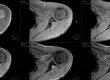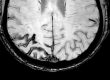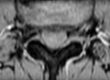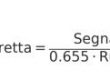Un’apparecchiatura RM è costituita da componenti hardware dedicate interconnesse da un complesso sistema software di controllo.
La principali componenti hardware sono:
- -magnete principale
- -bobine di gradiente
- -bobine a radiofrequenza (trasmettitore RF)
- -bobine ausiliarie (poste attorno al magnete principale)
- -sistema di acquisizione del segnale (ricevitore)
- -sistema per la digitalizzazione e successiva elaborazione del segnale
- -consolle di visualizzazione e registrazione delle immagini
- -compressore (chiller) dell’elio (per magneti superconduttori)
Il magnete principale, come abbiamo visto, può essere permanente, resistivo o superconduttivo; deve essere statico e omogeneo e ha la funzione di orientare (polarizzare) gli spin protonici. Quanto più alta è l’intensità del campo tanto più è elevato il rapporto segnale rumore (SNR) dell’immagine.
Le bobine di gradiente creano delle variazioni di campo magnetico lungo i tre assi spaziali che consentono di “localizzare” il segnale proveniente dai protoni. Ogni gradiente è lineare lungo l’asse a cui è applicato e uniforme rispetto agli altri due. Tali bobine sono realizzate con avvolgimenti di conduttori percorsi da una corrente che viene modulata diversamente a seconda della sequenza di eccitazione. L’unità di misura dei gradienti è Tesla/metro e i valori tipici sono compresi tra 20 mT/m e 100 mT/m.
Le bobine a radiofrequenza hanno il duplice scopo di creare un campo magnetico oscillante perturbante gli spin protonici e rilevare il moto di precessione della magnetizzazione trasversale. Esse sono costituite da elementi induttivi e capacitivi dal cui accoppiamento dipende la loro frequenza di risonanza. La bobina a RF più grande è quella posta all’interno della macchina, bobina “body”, le altre bobine sono esterne e vengono posizionate sopra il lettino a seconda dell’indagine richiesta. Tali bobine possono essere di tre tipi: riceventi e trasmittenti, solo trasmittenti, solo riceventi. Le bobine riceventi e trasmittenti trasmettono il campo magnetico oscillante Bosc, responsabile del fenomeno della “risonanza” dei protoni alla frequenza di Larmor, e ricevono l’energia proveniente dall’eccitazione della “sezione” esaminata. Le bobine solo trasmittenti sono usate per creare il campo perturbante oscillante e vengono accoppiate alle bobine solo riceventi che captano il segnale degli spin. Esistono diverse famiglie di bobine a radiofrequenze, ciascuna dedicata a particolari tipi di indagine. Sommariamente si possono distinguere bobine di volume, circondanti il distretto anatomico studiato, bobine di superficie “appoggiate” all’oggetto di studio, bobine ad uso interno, ad esempio a catetere. Generalmente le bobine di superficie sono solo riceventi mentre quelle di volume sono riceventi e trasmittenti e quelle ad uso interno possono essere solo riceventi o riceventi e trasmittenti. Quando si impiegano bobine solo riceventi la trasmissione del campo magnetico oscillante è affidato alla bobina “body” della macchina.
Le bobine ausiliarie sono di due tipi: bobine di shimming e bobine di schermatura (shielding). Le bobine di shimming creano dei piccoli campi magnetici che sommandosi a quello principale lo rendono più omogeneo consentendo pertando di mantenere il più costante possibile la frequenza di Larmor della zona di interesse. In aggiunta o in sostituzione di queste bobine a controllo elettronico talvolta vengono impiegati degli elementi di materiale ferromagnetico che, posti nelle vicinanze del magnete principale, ne modificano le linee di flusso (shimming passivo). Le bobine di schermatura possono essere attive (controllate elettronicamente) o passive (semplici avvolgimenti) e creano un campo magnetico ausiliario in grado di annullare localmente gli effetti del campo magnetico principale o dei gradienti nei punti in cui non sono necessari, ad esempio all’esterno del magnete.
Il segnale captato dalla bobina di ricezione ha una potenza molto bassa, nell’ordine dei milliwatt, per cui deve passare attraverso un preamplificatore a basso rumore di fondo che lo porta ad una potenza nell’ordine dei kilowatt. I segnale preamplificato, attraverso miscelazioni con frequenze di riferimento e filtraggi, viene portato ad una bassa frequenza e, attraverso due rilevatori di fase sfasati di 90° l’uno rispetto all’altro, viene sdoppiato in una componente in fase e una fuori fase (rivelazione in fasatura). Il segnale (coppia di segnali) prima di essere digitalizzato subisce ulteriori filtraggi e amplificazioni.
Il segnale analogico ricevuto dal sistema di acquisizione viene digitalizzato, ossia convertito in una serie di bit. Il criterio con cui avviene la digitalizzazione dipende dalla velocità di campionamento e la risoluzione spaziale desiderata. L’operatore scegliendo la banda di campionamento agisce sulla velocità di digitalizzazione del segnale e sul rapporto segnale rumore. A basse bande di campionamento corrispondono tempi di acquisizione del segnale più lunghi e rapporto segnale rumore alto, viceversa ad alte bande di campionamento corrispondono tempi più brevi e intensità di segnale inferiore. Il segnale digitale viene Fourier trasformato da un elaboratore che, partendo dallo spazio K, arriva a creare l’immagine finale.
L’operatore ha a sua disposizione una consolle per l’impostazione delle sequenze di acquisizione e per le successive fasi di visualizzazione, elaborazione, archiviazione e stampa delle immagini.
Il chiller è una pompa di raffreddamento che viene impiegata nei sistemi a magnete superconduttore. Il fluido impiegato come refrigerante è un criogeno, elio liquido a 0,95K pari a -272,22 oC, che mantiene gli avvolgimenti superconduttori (solitamente leghe di Niobio, Nb, e Titanio,Ti) ad una temperatura pari a circa 1,9 Kelvin